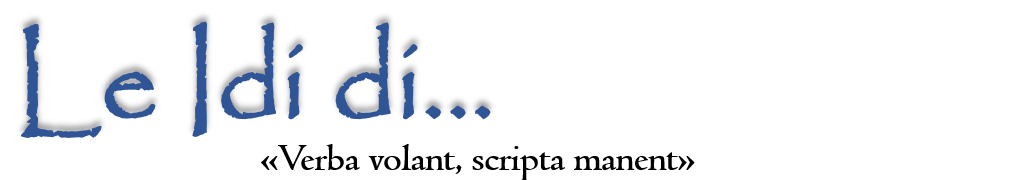Di Ginevra Augello.
Agli inizi del XX secolo Sigmund Freud sosteneva che tre fossero i duri colpi che avevano infine spezzato quell’ideale antropocentrico fortemente radicato nella cultura occidentale: la teoria eliocentrica, che aveva strappato all’uomo la sua centralità nell’universo, l’evoluzionismo di Darwin, che aveva reso l’uomo un animale come gli altri ed infine la psicoanalisi, che aveva sottratto all’umanità anche il controllo sul proprio io. Questi tre pilastri o meglio – volendo attenersi al pensiero freudiano – queste tre diverse applicazioni della scienza costituivano un paradigma, oggettivo ed inattaccabile, che tuttavia si limitava a confermare una concezione dell’esistenza già presente nell’antichità, secondo cui l’umanità non sarebbe che una parte di un meccanismo molto più complesso, in cui infine – come scrive Orazio nell’ode IV, 7 – non siamo che polvere ed ombra. È da tale conclusione che deriva uno specifico modello umano onnipresente nella storia letteraria, un calco dell’eroe tragico che tuttavia acquista un nuovo nome: è il vinto.
Si tratta di una figura archetipica dalle numerose declinazioni, che osserveremo da due punti di vista temporalmente e geograficamente diversi: quello della Pharsalia di Lucano e quello de Il cigno del poeta francese Baudelaire.
[…] Ormai era giunta
l’ora estrema, trasbordato sulla nave faria,
aveva perduto l’autorità su di sé. Si preparano a stringere
il ferro i crudeli sicari del re. Come vide la spada sopra di sé
si coprì il volto ed il capo, sdegnato di offrirlo
scoperto alla fortuna; allora chiuse gli occhi
e trattenne il respiro, perché non voleva emettere grida
e macchiare con gemiti l’eterna fama.
E quando il funesto Achilla gli trafisse il fianco,
assecondò il colpo senza alcun lamento
e guardò il crimine e mantenne immobile il corpo
e provò a sé stesso, morendo, chi fosse e queste parole rivolse nel proprio cuore:
«I secoli che mai taceranno le imprese romane
mi osservano, e l’evo futuro guarda da ogni parte
del mondo la fedeltà e la nave di Faro: ora pensa alla fama
I fati sono trascorsi favorevoli nella tua lunga vita,
non sanno i popoli, se non lo proverai nella morte,
che tu hai saputo sopportare le avversità: non cedere al disonore
e non dolerti di chi esegue il volere del fato: qualunque sia la mano che ti colpisce,
è la mano di tuo suocero. Lacerino e disperdano pure le mie membra,
sono fortunato, dèi celesti, e nessun dio potrà prendermi questo.
Mutano nella vita le circostanze favorevoli:
non si diventa con la morte infelici. Cornelia e il mio Pompeo
vedono la mia uccisione. Ancor di più resisti, ti prego,
dolore, e arresta i lamenti; se mio figlio e mia moglie mi ammirano nella morte, mi amano».
Il climax del libro VIII della Pharsalia coincide con la morte stoica di Pompeo, che nel suo monologo finale esprime quel valore tanto centrale nell’Eneide virgiliana: la pietas. Tuttavia, questa virtù, che per Virgilio – con piena aderenza allo stoicismo – rappresentava una sottomissione alla divinità, volta a condurre l’umanità verso quel futuro positivo che il fato aveva già stabilito, in Lucano diviene il simbolo della fine di un’era, quella dell’acme di Roma. Non a caso il poeta decide di legare il concetto di pietas alla figura di Pompeo, un personaggio positivo se contrapposto al brutale ritratto di Cesare dipinto nell’opera, ma che con la sua sconfitta permetterà al suo rivale di prendere il potere: è l’antefatto dell’età imperiale tanto criticata da Lucano.
In questo senso, quella che potrebbe apparire come l’eroica fine di un valente condottiero si spoglia della sua onorevolezza, assumendo i connotati dell’ambitiosa mors, intesa come la fine insensata e priva di utilità per la res publica, che tanto verrà criticata da Tacito. Così, la scena descritta da Lucano comincia ad incrinarsi, perché in questo caso il vinto è una vittima di sé stesso: mentre nell’Iliade, Ettore – di fronte alla furia omicida di Achille – cerca in un primo momento di fuggire per salvarsi la vita, Pompeo di fronte alla morte decide di assecondare il colpo, curandosi soltanto di apparire forte ed impassibile. Solo così la sua storia lascerà un segno e verrà ricordata dalla posterità e solo così i suoi cari potranno amarlo: se facesse altrimenti, soltanto il disonore lo attenderebbe. Eppure, questa sua capacità di sopportare le avversità – da lui stesso ricordata nel suo monologo – non fa altro che trascinarlo verso un fato avverso, al quale lui si affida ciecamente. E dunque a quale scopo affidarsi alla sorte, seguendo l’ideale del saggio stoico? Secondo lo stoicismo tradizionale, che Seneca propone nel suo Hercules Furens, ribellarsi al fato significa compiere un gesto insensato e contro natura, che porta solo a risvolti disastrosi, poiché la sorte, in quanto forza ordinatrice, usa ogni mezzo a sua disposizione per rimettere l’uomo sulla via prestabilita. Così, Ercole è colpito dalla follia e massacra la sua famiglia.
Tuttavia, Lucano pone un interessante quesito: se il futuro che il fato ha predisposto è tutt’altro che roseo, ha davvero senso questa sottomissione, questa sopportazione? La morte di Pompeo, la sua accettazione del proprio destino di sconfitto, ha un qualche significato? La risposta offerta dal poeta è senza dubbio negativa. Si avverte, in questo senso, un senso di continuità rispetto al progetto iniziato dal tragediografo Euripide di critica ad una concezione provvidenzialistica della realtà. Allo stesso modo, tuttavia, si avverte l’assenza di un vero eroe tragico: nessuna delle figure presentate acquisisce quei tratti tipicamente superoministici dei protagonisti delle tragedie euripidee, restando così incapace di influire sulla realtà, secondo una concezione fortemente pessimistica. Per tale ragione, lo stesso Catone, unico modello a tutto tondo positivo proposto da Lucano, si configura come un vinto tanto quanto Pompeo: sebbene egli decida di distaccarsi dallo stoicismo, rifiutando di sottomettersi al fato, rimane tuttavia impotente ed incapace di superare la crisi in atto, che ha condotto a questa guerra più che civile. Nel Bruto minore di Leopardi, queste medesime condizioni portano l’alter-ego del poeta a togliersi la vita, ponendo fine a questo vano conflitto umano contro un destino ingiusto, ma Lucano rifiuta questo modello, definendone uno molto simile a quello che verrà in seguito proposto da Tacito. Quest’ultimo, infatti, nel descrivere la figura del suocero Agricola, gli attribuisce caratteristiche simili a quelle del Catone della Pharsalia (“amante della giustizia, custode della rigida onestà, integro nell’interesse di tutti”) e loda l’opposizione verso un regime ingiusto, senza tuttavia cedere ad inutili gesti estremi, come il suicidio, o all’abbandono della propria virtù, anche se ciò implica non vedersi riconosciuto l’onore che si meriterebbe.
L’analisi presentata finora ha messo in evidenza una caratteristica fondamentale della figura del vinto nella cultura classica: questa tende ad avere delle forti connotazioni filosofiche. Ciò è dovuto ad un’eredità che i Romani acquisiscono dai Greci: il conflitto tra una civiltà della vergogna, in cui l’agire umano è dettato dal riconoscimento civile, ed una civiltà della colpa, in cui l’io diventa preponderante e si scontra con la civiltà stessa. Tale conflitto, trattato esaustivamente dai tragediografi Sofocle ed Euripide, conduce alla fondazione di una nuova civiltà: la civiltà dell’angoscia, che ha perduto i suoi riferimenti e cerca di trovare un nuovo ordine. Si tratta della stessa società alla deriva descritta da Apollonio Rodio nelle sue Argonautiche, in cui la mancanza di un senso civile costruisce un’umanità derelitta, una società di vinti tormentata dall’impotenza, che li ostacola in ogni loro azione. A questa terza civiltà appartengono Lucano e Tacito e tutta la cultura a loro successiva, che sebbene infine si slegherà da quell’approccio filosofico così tipico della cultura classica, tuttavia non smetterà mai di mettere in evidenza quella dissonanza tra l’individuo e la società a cui dovrebbe appartenere. Questo preponderante senso di anomia si amplifica nella letteratura del XIX secolo, che mai manca di dare voce ai suoi vinti e al loro dolore, come fa Charles Baudelaire nella sua poesia Il cigno.
Andromaca, io penso a voi! Quel fiumiciattolo,
misero e triste specchio dove un tempo rifulse
l’immensa maestà delle vostre pene di vedova,
quel Simoenta mendace ingrossato delle vostre lacrime,
ha d’improvviso fecondato la mia fertile memoria
mentre attraversavo il Carosello nuovo.
La vecchia Parigi non esiste più (l’aspetto di una città
muta più presto, ahimé, che il cuore dell’uomo),
soltanto in spirito vedo tutto il campo di baracche,
il mucchio di capitelli appena sbozzati e di fusti di colonne,
le erbe, i grandi massi inverditi dall’acqua delle pozzanghere
e, nel brillio delle vetrine, la confusione delle cianfrusaglie.
Laggiù stava un tempo un serraglio,
e là io vidi, un mattino, all’ora in cui sotto i cieli
freddi e chiari il Lavoro si sveglia, e gli spazzini
levano un oscuro uragano nell’aria silenziosa,
un cigno evaso dalla sua gabbia:
con i piedi palmati fregava l’arido selciato,
trascinando il bianco piumaggio sul terreno accidentato.
Presso un ruscello secco l’animale, aprendo il becco,
immergeva febbrilmente le ali nella polvere,
e diceva, il cuore tutto memore del suo bel lago natio:
«Quando scenderai, acqua, quando esploderai, fulmine?».
Vedo quel misero, strano e fatale mito,
verso il cielo, talvolta, verso il cielo ironico
e crudelmente azzurro – come l’uomo di Ovidio
sul suo collo convulso innalzando l’avida testa –
in atto di lanciare rimproveri a Dio!
Parigi cambia! Ma nulla è mutato nella mia malinconia:
palazzi nuovi, impalcature, massi,
vecchi quartieri, tutto in me diviene allegoria,
e i miei ricordi più cari sono grevi come rocce.
Così, dinanzi al Louvre un’immagine m’opprime.
Penso al mio grande cigno (ai suoi movimenti folli),
ridicolo e sublime come gli esuli,
e divorato da un desiderio senza requie. E penso a voi,
Andromaca, caduta dalle braccia d’un grande sposo,
come un vile capo di bestiame, sotto la mano del superbo Pirro
curva su una tomba vuota, estatica, penso a voi,
vedova di Ettore e sposa di Eleno.
Penso alla negra smagrita e tisica,
scalpicciante nel fango, in atto di cercare, col suo occhio sconvolto,
gli alberi di cocco assenti della superba Africa
dietro il muro immenso della nebbia;
penso a chiunque ha perduto quel che non si ritrova
mai più, a coloro che si saziano di lacrime
succhiando il Dolore come una buona lupa,
ai magri orfanelli che appassiscono come fiori!
Così, nella foresta ove il mio spirito si rifugia,
un vecchio Ricordo suona a perdifiato il suo corno.
E penso ai marinai dimenticati su di un’isola,
ai prigionieri, ai vinti… e a molti altri ancora!
Il componimento – probabilmente il più celebre tra i Quadri parigini, seconda sezione della raccolta I fiori del male – costituisce il ritratto di un’epoca, vista da una prospettiva esterna: non è il racconto di un uomo del suo tempo, ma di un emarginato incapace di seguire quella che Verga definiva la fiumana del progresso, restando un individuo sano in una società di alienati. Ostracizzato dal mondo a cui dovrebbe appartenere, l’io lirico riesce ad identificarsi solo con i vinti, che hanno perduto quella forza degli antichi di tenere la testa alta, cercando di trovare un nuovo ordine, un nuovo canone di riferimento per interpretare la realtà: rimangono soltanto “coloro che si saziano di lacrime, / succhiando il Dolore come una buona lupa”. Non a caso la prima figura richiamata da Baudelaire è l’infelice Andromaca: non un condottiero come il Pompeo di Lucano, né l’ideale di uomo politico rappresentato dall’Agricola di Tacito, ma una vittima collaterale di un conflitto su cui non può esercitare alcuna influenza. Si tratta di una spettatrice impotente, che si ritrova a perdere tutto ciò che ha di più caro senza poter fare nulla.
Usando Andromaca come riferimento, Baudelaire vuole stabilire un nuovo archetipo di vinto, che possa applicarsi alle vittime innocenti della nuova società industrializzata, che non hanno alcuna possibilità di migliorare la propria condizione. Quello spiraglio di redenzione lasciato aperto dagli autori latini citati in precedenza, quella possibilità seppur minima di opporsi ad un destino ingiusto vengono spazzate via, oscurate da quel senso di angoscia che impedisce un’identificazione con la società a cui si dovrebbe appartenere. In tal senso, Baudelaire sembra incarnare il tema fondante dell’Amleto di Shakespeare, in cui la rottura tra i valori di un’età dell’oro ormai trascorsa ed il sistema corrotto di una nuova era – esemplificato dalla frase “C’è del marcio in Danimarca” – generano una crisi insanabile nel protagonista, che sfocerà in tragedia. Si tratta di un malessere che deteriora il mondo circostante, infettando gli uomini con questo male di vivere che genera in loro quel senso di anomia precedentemente citato, che da un lato trasforma il poeta stesso in un emarginato, oggetto di scherno, come accade ne L’albatro di Baudelaire; dall’altro, schiaccia i più deboli. Così, Andromaca diventa un punto di riferimento, in cui ci si può immedesimare, come anche Ofelia, personaggio dell’Amleto a cui Rimbaud dedicherà un componimento che porta il suo nome, in cui la giovane è descritta come un fantasma che vaga su un fiume nero, così diverso dalla fanciulla che era in vita, quando riusciva ad ascoltare nel cuore il canto della natura. Anche nel caso di Ofelia, la gioia di una vita serena viene spazzata via all’improvviso, ma a differenza di Andromaca questa rottura riguarda la sua sfera interiore: sogni troppo grandi la perseguitano e le causano tormento quando si infrangono contro lo scoglio della realtà, uccidendola pian piano.
Questi sono i vinti di Baudelaire, che non manca di dedicare Il cigno all’uomo che già li aveva descritti: Victor Hugo, autore di Les Misérables. Tuttavia, il poeta non si limita a celebrare gli esempi di umanità derelitta della sua epoca – la “negra smagrita e tisica”, i “magri orfanelli”, i “marinai dimenticati su di un isola” ed i “prigionieri” -, ma si annovera tra loro. Da una parte, Baudelaire porta avanti uno dei temi centrali della sua poesia: il decadimento della figura del poeta, che ha perduto il suo ruolo di guida morale (Perdita d’aureola); dall’altra, egli vuole mostrare gli effetti di una totale perdita di centralità dell’uomo, divenuto solo un elemento insignificante in una società che si sviluppa incurante della sua esistenza. Tale elemento emerge chiaramente nella descrizione del cigno, un alter-ego del poeta stesso, ritratto mentre cerca affannosamente l’acqua, trascinando il piumaggio bianco per le strade polverose della nuova Parigi industrializzata. Non solo si enfatizza la contrapposizione tra la maestosità di questo animale e la sua pietosa condizione – tema già presente ne L’albatro -, ma si dice che alzava il capo verso il cielo come l’uomo di Ovidio, per lanciare rimproveri a Dio. Quest’ultima frase è in realtà pregna di un’amara ironia.
Ovidio aveva affermato la superiorità dell’uomo sugli altri animali per la sua capacità – conferitagli dalla natura – di poter stare eretto e guardarsi intorno grazie al collo flessibile, affermazione ripresa anche da Seneca nel De otio e da molti autori dell’Umanesimo. Tuttavia, Baudelaire nega questa interpretazione: l’uomo non è favorito per la sua condizione e nessuno si cura di lui, né la natura, né gli dèi, entità verso le quali l’umanità può solo lanciare rimproveri che resteranno inascoltati. Si tratta di una concezione pessimistica della realtà che affonda le sue radici nel Romanticismo. In particolare, è impossibile non citare il Dialogo della Natura e di un Islandese di Leopardi, che nega ogni concezione teleologica dell’esistenza, presentando un’interpretazione materialistica e meccanicistica, basata sui principi di causalità e casualità. La stessa idea è presentata anche da Shelley nel suo Ozymandias, in cui si mette in luce quanto piccolo sia l’uomo e quanto ininfluenti le sue azioni di fronte alla forza della natura. Così, il poeta diviene probabilmente il più grande dei vinti dell’età moderna: egli non solo soffre di quel male di vivere comune a tutti gli uomini, ma è conscio delle sue cause e più di chiunque è consapevole della propria impotenza, poiché ha sperimentato in prima persona il rifiuto della società, che non vuole più seguire un vate. L’unica cosa che egli può fare è osservare la città che continua a trasfigurarsi, “divorato da un desiderio senza requie”, mentre prima di ogni altro uomo acquisisce la consapevolezza che non vi è altro fine dell’esistenza umana se non la sofferenza.