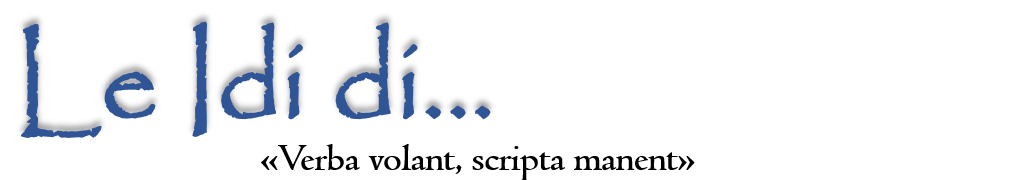di Virginia Puma, II D
Il Bambin Gesù è davvero un bell’ospedale. No, dico davvero: si trova al centro di Roma e affaccia sul Gianicolo, non avrei potuto chiedere luogo migliore dove essere ricoverato. In realtà, dopo la bravata che ho fatto, non meriterei di certo il lusso, ma sono un ragazzo fortunato. Che posso farci! Mamma e papà dicono che ho avuto una botta de culo e che sono vivo per miracolo, ma secondo me esagerano. Certo, non capita tutti i giorni di finire nel reparto dei pazzi, però mica l’ho fatto apposta, o no? All’inizio nemmeno avevo compreso dove mi trovassi né tantomeno il perché, forse i sedativi non me facevano capì niente. Poi, quando mi hanno levato la flebo e staccato le ventose infernali dell’ECG (che per la cronaca rendono impossibile l’abbioccarsi in pace tanto quanto le zanzare alle quattro di notte in pieno agosto), ho iniziato a fare mente locale e me so’ impanicato. Mi sembrava di essermi svegliato da un sonno eterno che avrei preferito non venisse interrotto: tra strizzacervelli, infermieri e altri operatori sanitari che me ronzavano attorno ho pensato che dalla porta sarebbero sbucate pure le guardie a farmi l’interrogatorio. Che poi manco riuscivo a dare un risposta di senso compiuto, ero come drogato in un seminterrato senza finestre e infestato da ‘sto odore asettico condito da ‘na luce bianca perennemente puntata nelle mie pupille. Avevo completamente perso la percezione del tempo, non distinguevo più il passare delle ore: per me 10 minuti e mezza giornata erano diventati la stessa cosa. Ogni tanto chiedevo a Massimo, l’infermiere di turno, l’orario e lui tutto scocciato (‘sto coattone!) mi rispondeva: “A Mattè, e basta! Che pensi che se me chiedi che ore so’ ogni 5 secondi te se vengono a prenne prima?”. Una volta me svegliai nel bel mezzo della notte convinto fosse mattina presto e accesi la luce per leggere un libro: manco il tempo di sfogliare la prima pagina che subito Cinzia, n’altra infermiera (‘na ciociara, per capirci), irruppe nella mia stanza urlando: “A Mattè, macché te sei impazzito? Torna a dormì che svegli il compagno tuo!”. Da quell’episodio ho campato di sonniferi. C’era questa tirocinante però che mi faceva simpatia: si occupava dei prelievi e dei test delle urine a cui venivo sottoposto praticamente ogni giorno, quasi dovessero succhiarmi via l’anima. Si chiamava Flora e tutte le volte mi ripeteva: “Mattè, nun te preoccupà, sei un ragazzetto buono, vedrai che te mannano a casa il prima possibile”.
Dopo mesi, quasi anni, chiuso in casa, ero convinto che un ambiente del genere mi sarebbe stato indifferente, del resto non volevo che il mondo mi vedesse. Ironico: dal momento che ogni singolo meandro di quel reparto era tappezzato di stramaledettissime telecamere pronte a monitorare qualsiasi mio movimento. Ma nessuno m’ha mai spiegato il motivo del mio fremere al solo pensiero di tornare in
zona mia. Sì, esatto: quel quartiere che ho sempre insultato perché non mi faceva sentire a casa, come sei poi mi sentissi accolto da altre parti. Eppure in quel momento volevo solo poter uscire dalla metro B e mangiare al McDonald’s di Tiburtina o magari andare in stazione e prendere il regionale verso Trastevere. Mi sarebbe bastato anche solo il rumore degli autobus o la caciara nel cortile di scuola mia. Pure magnà là dentro era un problema. Mi sono rifiutato per giorni prima di riuscire a mandare giù quella pastina in brodo insieme alla terapia. Volevo sparire, soprattutto quando venivano a trovarmi i miei genitori. Si alternavano quell’ ora pomeridiana in cui mi permettevo di piangere, l’unico spazio che mi ritagliavo per lasciarmi andare e pensare che di stronzate ne avevo fatte, ma mai come questa. Loro continuavano ad amarmi e a preoccuparsi per me, nonostante gli avessi fatto il torto più grande de tutti. E io mi sentivo
solo lo stesso. La verità è che mi ci ero messo io in quella situazione, ma non sapevo come scappare da me stesso. Ero incasinato forte ma guardavo con superiorità gli altri poracci ricoverati con me, perché avevo bisogno di credermi migliore di loro. Volevo convincermi che i miei problemi non fossero poi così gravi: avevo fatto un errore, ma mica giravo con le braccia fasciate o il sondino su per il naso. Dopo quattro giorni sono riuscito a vedere il Gianicolo da fuori e a calpestarlo con le mie vecchie ciocie. Non importa se controlli il meteo o te vesti a cipolla: a Roma ad Aprile come fai sbagli.