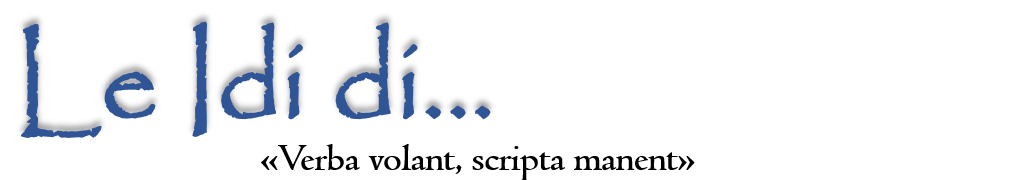di Marco Occhiuto, II C
«(…) Celeste è questa
Corrispondenza d’amorosi sensi,
celeste dote è negli umani…»
– Ugo Foscolo
Era l’ora che il sole, colorato d’arancio, diffonde la sua luce, d’un colore dolce, tra i nudi rami degli alberi, arrancando tra le cimase, tra i ciliegi sfioriti, tra i platani scheletrici. Stampava sul marciapiede stanco e scalcinato le ombre innumerevoli e prostrate di gente in cammino, senza sosta, sin dalle prime luci. Adesso, che tutto volgeva alla sera, alla placida sera, quelle luci medesime del mattino, giunte così di fretta, parevano, intenerite dal tempo e dal tramonto imporporate, infondere nell’animo di tutti l’appagante serenità di una tenebra meritata. Più non si poteva fare. Lo attestavano le gambe che sembravano cedere a ogni passo, e la stanchezza smorta caduta, gradualmente, sul volto dei passanti.
Roma era indorata da quel sole languente; quel sole che, qualche ora poi, sarebbe di nuovo apparso, vigoroso come un tempo, sul crinale di remote montagne, ad annunciare un nuovo giorno.
Si fosse fermato là il tempo! A vederla, Roma, dal Gianicolo, che meraviglia arcana! Che sussulto di sensi!
Là quasi lasciva, appollaiata su sé stessa, languida e distesa, addormentata, sfavillante di luci artificiali – sempre più –, in armonia con lo spegnersi del giorno. Quella Roma senza età, senza timori, che pareva là sciogliere i suoi freni solidi e maturi all’abbraccio tenerissimo del mondo. Pareva non saper dire di no a quella natura che se l’abbracciava, con gioia, e se la cullava, tutta quanta, quasi che gli strepiti delle auto, i lamenti acuti dei tram, i suoni della vita si fossero arrestati, attoniti anche loro dinanzi a quel prodigio là.
Avete presente, sì, quando la giornata declina, quando gli uffici si svuotano, e per le strade aggomitolate sembra muoversi spensierato solo qualche padrone – forse un po’ nevrotico – che porta a spasso il cane – e il cane lo porta di qua, di là, di giù, di su; e a noi viene, per così dire, da ridere – ?
L’avete presente, dico, quel momento là, in cui il lavoro pare un incubo trascorso, ma non già superato, e ci volgiamo tutti, come liberati, verso i pericoli sormontati, le critiche subìte, gli esami affrontati, e ci diciamo: è andata. Ce l’avete, dico, presente?
E di quei guai rechiamo nel fisico ancora l’affanno, ancora la trepidazione, che si traduce, disarmata però, in un palpito veloce, riemerso d’improvviso, in una trepidazione latente, e tuttavia pronta, quando appena vellicata, a rifiorire sulla pelle, sotto forma d’un brivido repentino e sconvolgente.
E questi affanni, che sono quelli della vita, si dissolvono quanto dolcemente sul far della sera, piegati anche loro dal fascino familiare di una vita rasserenata, di una giornata superata, di un camino caldo, acceso con cura per il nostro arrivo!
Si annacquano disarmati e dolci, come una goccia d’assenzio in un barattolo di miele, quando il crepuscolo d’oro viene a distendersi su di loro, e li mette a tacere fino all’indomani.
La luce indorata muore languida tra le fessure dei sanpietrini, avvolge, trepidante, il marrone di qualche ramo, e colora di rosso qua e là una foglia riarsa che ciondola, e si posa lievissima e discreta, senza recar fastidio, sui visi come ristorati, come più freschi, delle persone; e, ancora, ne vivifica le pupille, le approfondisce, sublimemente, e ne fa un capolavoro stillante emozioni, sensazioni, corrispondenze. Evidenzia qualche perlaceo filo di capelli, che scende, sfuggito al resto, sulla fronte; e strappa alle fronde quel profumo dolce, che rievoca i tempi immemori di un’infanzia arcana. Si ridestano, nell’uomo, quelle sensazioni primarie, quasi banali, eppure le più vere, le più sante, le più gioiose; quella semplicità della vita, quel brillare dei sensi risvegliati, che s’impongono nel nostro animo, sia pure provato, e ci fanno dire: «Non è poi tanto male questa esistenza».
Vediamo in noi la gioia, come rinnovata, come ripescata dai ricettacoli obliati dei primi sussulti, delle prime parole, dei primi sensi; e la rivediamo negli altri, raggianti, belli, ristorati. Chiunque ci pare amico. E tra la gente s’intesse, divina, una celeste corrispondenza, un sentire comune della vita; s’impone la consapevolezza di essere tutti sulla stessa barca. E così edotti, ci immortaliamo santamente nell’atto d’un mutuo sorriso, d’una dolce reciproca parola, d’una positività impostasi in ognuno, a cui non possiamo fare più argine.
E siamo, certo, convinti che la vita è bella; e svaporano le ansie, le malinconie, nella convinzione che tutto scorre, come la luce che sdrucciola ora sul ramo, e incespica poi in qualche fronda scarna, su qualche rametto, fino a poi a tacersi, muta, nell’ombra.
Ce l’avete presente quella sensazione?
Quella sensazione che, poi, dev’essere quella che si prova quando il fiore della giovinezza incomincia a chinarsi sul suo stelo e, non troppo lontano, si cominciano, per la prima volta, a intravedere le forme buie, disincantate, d’una fine più vicina. Su quei maturi gradini della vita, perde allora tutto il suo peso; e, per forza di cose, si accende nei più una sublime leggerezza.
Ma via! Non è il momento di pensarci, e non so dire, d’altronde, se è così veramente: ancora m’irride la bella gioventù.
Ritorniamo, dunque, a quella sensazione là.
Ebbene, devo confessare che era tanto, ormai, che io non la sentivo più.
Come ciò mi sia accaduto, forse vi chiedete. Io non lo so – o, meglio, ne conosco la causa, che vi dirò, ma non so dire precisamente che cosa sia successo dentro di me, nel mio animo – . E il paradosso è proprio questo: che provo a spiegarlo a voi.
Forse la scrittura mi recherà un raggio di luce.
Voi, tornando a casa, in questi momenti di pace, trovate forse, che vi attendono, visi amici, parenti; sentite forse, fin dalle scale, il fumo odoroso di una cucina operosa; o udite l’assordante scampanellio del collare del vostro cane, che vi aspetta ritto sulla porta, con la lingua di fuori, esuberante, pronto a saltarvi addosso, e leccarvi via la stanchezza del giorno. Immaginate, ristorati, il candore fresco delle lenzuola di bucato, dove vi distenderete a breve, dopo aver appagato la fame e la sete, e affogato nel vino le residue trepidazioni del giorno.
Così, allegri, ve ne andate per la strade, gongolanti, sereni, e affondate qualche occhiata nel cielo, spostandola tra i rami ancora fioriti di qualche platano e le forme peregrine delle nuvole disparse. La vita vi scorre addosso così, e si consuma, uguale, a scansioni diverse, per il corso d’una monotona giornata.
È da tempo, ormai, che la mia casa non mi sembra più casa. Ne odio il quartiere, la gente, i rumori; ne odio finanche quell’alito che cova in ogni casa, che imbeve di sé le suppellettili, che si affonda nelle venature dorate del legno; che si è posato, da tempo innumerevole, sulle foto sbiadite che giacciono, lontane nel tempo, lontane nello spazio, sul mobiletto vicino al mio divano, e che ritraggono tempi trascorsi di felicità perdute.
Ne odio i colori, i quadri cupissimi e grigi; la cucina piccola.
Voglio scapparmene, la mattina alle prime luci; e farvi ritorno più tardi che posso, dopo che niente che vi è in giro è riuscito a soddisfare la mia insoddisfazione.
Quella casa, accasciata morente e scialba su un marciapiede bucherellato, diviene, nei miei pensieri, l’ultimo approdo di minor tristezza.
Ma, steso meccanicamente sulle lenzuola, nubivaghi pensieri, staccatisi da me, dipartono verso zone remote e misteriose del mondo, e provano a trarvi, se v’è, qualche ragione, qualche ultimo senso, qualche estremo appiglio vitale, che mi riporti a viverla, questa sciocchezza qua, la vita …
Volo in alto, lassù nel cielo, nel tentativo di strappare all’immensità dell’orizzonte un minuto senso della vita, il saluto lontano e trascendente di un caro scomparso, il cui volto, la cui voce, giacciono forse, immortalati, in quell’infinità là, e la permeano di un’essenza che io non riesco a cogliere.
A me nessuno attende, tornato a casa; è vuota, desolata, deserta; la vivono ancora, come ho detto, sbiadite e ingrigite fotografie in bianco e nero, brillanti appena di pupille bambine, di sorrisi puerili, di maternissimi abbracci. E ora? Ora quelle foto non fanno che ridestarmi, in petto, una malinconia struggente, un sogno irrealizzato nutrito di rimpianto e d’abbandono.
La vivono piccoli insetti fugaci, velocissimi, che si dileguano come accendo la luce; la vive la polvere, addormentatasi da tempo ormai sulle mensole, sui braccioli dei divani; la vive il pulviscolo minuscolo, quando è investito da esili raggi di sole.
L’alba, dovreste vederla, a casa mia. Mi trova già desto.
Ne percepisco i primi sussulti, quando, incespicato nel mio pensare – che oscilla dallo scricchiolio acuto di una porta vecchia alla malinconia filosofica ed esistenziale per i miei amori sciupati –, dagli scuri della finestra vedo arrivare i raggi, primi, di un nuovo giorno: esili, pallidi quasi, timidi m’entrano in casa, invadenti, disordinati, confusi; si aggrappano alla prima cosa che trovano.
Eccoli! Tutti intenti a circondare di luce novella quel maglioncino scucito e sgualcito buttato per terra, ad evidenziarne i contorni lanosi, i fili sparsi e fuggevoli di tessuto; eccoli, che proseguono a tentoni: arrancano, piano, a gradi, a mano a mano, tra le mattonelle, e s’annidano vergognosi nelle fessure di queste. Poi continuano, più saldi, inesorabili. Un fascio di primizie luminose illumina parte considerevole del pavimento di ghiaccio. Salgono, salgono ancora, a tentoni; si buttano, rapidi, sussultanti, sui piedi del letto, e salgono, salgono fino alla coperta che ciondola.
Eccoli, a salire ancora, salire! Toccano un po’ di tutto, indiscreti; mi toccano finanche la mano, che mi scivola via, sfuggita al resto del corpo, e che penzola con una certa inanimata rassegnazione giù dal letto, e tende a chissà che cosa. La toccano, quella mano stanca di fare, di creare; la illuminano, la designano viva, la ascrivono solenne alla vita. La luce gira intorno all’unghia rosea, e candida poi, e continua quindi a gettarsi sulle rughe delle dita, a modellarsi sulle pieghe della pelle, a indorare qualche pelo ribelle.
Quindi, di nuovo a tentoni, sul braccio; la luce sale lenta e rapida insieme sale, fino alla spalla nuda. Lemme lemme è giunta fino al viso. Le pupille sono invase dai raggi più vigorosi, giovani e ridenti.
Estranio, per un poco, alla vita, e mi sento un nulla che vive, un alito del niente fuggitivo, una sostanza catapultata nel tempo e nello spazio, così d’improvviso, e chiamata alla vita.
Estranio ai casi della vita. Vivo senza saper perché, o per chi. Vivo impelagato in dubbi che s’immillano, quanto più l’indaga il pensiero, come s’immilla indiscreta la luce, nella mia cameretta timida e segreta.
La notte occulta, dedita a se stessa là dove vive la nostra solitudine, mi passa così tristemente di dosso, come un treno di cari affetti che s’allontana, sciacquata via rapidamente e indocilmente dalla luce di un sole ridestato.
La luce, santo privilegio! I raggi, giovani e vecchi, gialli e vermigli, dell’aurora e della sera, paiono dirmi, sussultami, urlarmi: vivi! E illuminano di luce aurorale o serale l’umbratile penombra della mia esistenza. E, che io voglia o no, mi attestano, essi, in vita.
Ne ero onorato, prima almeno che quella luce stessa, che tanto mi lusingava, non si eclissasse negli occhi giovanissimi di chi, per pura connessione di anime e d’ideali, mi aveva voluto un bene grande.
Era quella stessa luce, che non sapeva più risvegliare, più rallegrare chi tra i miei giaceva in una terra oscura e muta.
All’ombra dei cipressi non batte più la luce? O là tutto avvolge l’oblio nella sua notte? Non tempo, non ore future, in quel porto esiziale della decadenza.
Ricordo ancora, come se presenti, quei momenti atroci di non molto tempo fa. Più il tempo scorre, più mi sembra impossibile che scorra senza di lui, e che inglobi, tra le altre cose, così naturalmente, anche la strabiliante crudeltà della sua dipartita.
Un tic tac d’orologio, una sedia scucita e verde smorto; una sala fredda d’ospedale, d’un candore di ghiaccio, che voleva suggerire forse purezza, e invece trasudava un sentimento orribile di trepidazione, di terrore e di lontananza.
Quella sala gelida d’attesa era permeata di non so quale incredulità suprema e triste, drammatica. Il mio aspetto stesso era negli altri. Tempo, quello, in cui crolla l’incrollabile illusione del progresso, del successo, della vittoria; quando, racchiusi in un medesimo dolore, ci vediamo gli uni negli altri; e quei volti disperati, sconvolti, gravi, nei quali ci imbattiamo, non fanno che esasperare il senso lancinante dell’impotenza e del dramma. In quei volti crollano tutti i voluttuosi inganni, in quei volti s’imprime, indelebile e grave e assoluto, il divieto alla speranza. Quel disastro della vita, che ci piomba addosso all’improvviso, magari durante una giornata luminosa, ci sembra inaccettabile; e tra di noi s’intessono, a ripetizione, gli stessi discorsi, e si ripropongono le stesse domande, si articolano le stesse considerazioni, come per esorcizzare il male, come per avere l’impressione di dominarlo, se non nella realtà, perlomeno in vuote e fugaci parole. Ma nessuna potenza ci viene da nessuno, e ci riscopriamo totalmente in preda di una solitudine disperatamente impotente; e ci sdegniamo che, intorno, tutto vada avanti come sempre, che qualche volto s’indori ancora nell’atto di un sorriso, e che tutto il mondo, in perpetuo giro, non si fermi anch’esso a contemplare, tutto insieme, la nostra tragedia.
Una tempesta densa ci devasta, ci sradica, ci sbatte senza posa, e gli alberi ancora fioriscono, e la gente, sparsa sulle strade come piccole nuvole nel cielo, ancora s’innamora, e le corolle sbocciano, esalando chissà quali straordinarie confusioni di profumi; e, inghiottiti dall’azzurro, si librano in alto, e cantano, dolcissimi cantano, i passeri; primavera non bussa, entra, infonde amori, infonde desideri, con mani di velluto ridesta sensazioni lontane, impalpabili, e fedeli ancora alla memoria – loro, come goccioline visibili appena per una fascio di luce … –. E si parla, in giro, di qualche futilità, di un futuro malinconico, di un fastidio; si ride, si scherza, irradiati dalle luci più vive di una nuova stagione, indolciti da quei profumi illibati, che ci giungono soavi e intonati alle narici; amore! canto! balli!, inutili sciocchezze della vita … e io, intanto, muoio. Questo è per noi inaccettabile e assurdo, che il mondo viva, danzi, canti perfino, all’infuori di noi e del nostro dramma.
Non so se l’avete a mente, questo tempo. Tempo che precede una notizia tragica.
Tempo pervaso di speranze umili, attente a non emergere troppo, costantemente in lotta con la realtà più disperata, che viene, momento dopo momento, ad estinguerle.
Agonizzano sempre più le illusioni, e quella eventualità tremenda che si credeva infattibile pare assumere, minuto che passa, le forme orribili e sciagurate della realtà.
Avete presente quelle attese là? Quando i secondi paiono gocciolare, e ciascuno si porta appresso la potenzialità del dramma, del fatto; e ci si sente morire dentro, mentre il disegno agghiacciante della vita si costruisce, mattone su mattone?
Ero così, in quella sala là, che ancora si ripresenta impetuosa e violenta nei miei pensieri, tutta bell’e fatta, perfetta, esattamente com’era.
Quel dolore disperato, temperato un poco da fuggitive e timide speranze, da ingenue e innocentissime illusioni, mi ruggiva dentro tutto insieme, senza che una goccia potesse uscirne; e si mischiava con la stanchezza inveterata, che avevo accumulato col passare di quei giorni, che erano come un’eternità d’inaudita sofferenza.
Di fuori, impietrito, incapace di manifestare la più insignificante emozione, sia di dolore, sia di speranza, sia di follia.
Non facevo motto. Chi mi stava intorno, e si trovava insieme con me nello stesso naufragio, sia pure per certi versi dissimile, provava a ricomporsi; a nascondere quegli occhi che non davano lacrime, e che pure ne recavano il segno.
Negli altri il mio aspetto, intorno il silenzio, dentro l’incredulità, la convinzione decaduta che la vita non potesse essere crudele tanto.
E invece lo era. Sentivo avvicinarsi quell’addio inesorabile, di cui percepivo con mano l’ormai irreparabile vicinanza; lo sentivo meno lontano ogni secondo che passava – ticchettio agghiacciante di un tempo inesorabile…–
Dinanzi a me icone, appesi al muro freddo e tacito santini di una santità muta, pregata – pensai più tardi – invano.
Ogni volta che si apriva quella porta, che portava in rianimazione, attendevo il peggio, l’annuncio di un’assurdità che avrebbe dato la morte alla mia vita.
Quell’annuncio lo vidi fare, prima, a una famiglia accasciata, stremata sul divanetto dirimpetto alla porta, con le pupille di una profondità immensa, madida per le lacrime brillanti e contenute; tutti abbracciati, come per ammortizzare quel colpo disperato e inaudito che veniva a violentarli, a disturbarli negli affetti più cari, e a sconvolgere per sempre, e senza rimedio, quelle esistenze senza più ragion d’essere. Che tenerezza mi facevano, così uniti in un comune dolore, in uno stesso fatale naufragio, il Cielo soltanto lo sa. Le pupille dell’uno affondate in quelle dell’altro, come per cogliervi una misera speranza che non c’era più o che, forse, viveva ancora, aggrappata a qualche illusione prossima a disfarsi. Il padre li teneva tutti insieme, estendendo le braccia sulla moglie e sugli altri figli. Come l’albero che, al venire della tempesta, si pianta con tutte le sue energie sulle sue radici, e si fa forza, e disperatamente rinsalda i suoi rami, piegati dal vento, e però cade, sfracellato sul suolo, in una rovina di rami nudi e spezzati, e contorti, e di germogli uccisi. Il tripudio d’immane dolore, di sofferenza indicibile, che si abbatteva su di loro, così deboli e indifese ed effimere creature, perdutamente impotenti, destava in me un senso sconsolato di ingiustizia, d’una gratuita perversità del mondo, della natura, dell’universo.
Non poteva essere vero. Eppure lo era. C’è ancora speranza che viva? Questo era il sentimento che, per misteriosa corrispondenza, ci raccoglieva nel comune mistero.
Quindi la porta si aprì, e si aprì per me.
Ricordo ancora la barella coperta da un velo bianchissimo, che mi passò davanti agli occhi, portata da un infermiere; affondai gli occhi fino in fondo al corridoio, finché quella si muoveva, finché la potei vedere. Un candore di velo si dissolveva, lucido, lungo un bianco corridoio, e velava sussulti, parole, sentimenti, ricordi, sensazioni; velava la vita, e d’un silenzio glaciale, irreparabile, irreversibile, malvagio come la cantilena macabra e inquietante d’un carillon; e, impietrito, morto anch’io insieme con lui, eppure pienamente presente al dolore che mi sovvertiva, stetti immobile a contemplare quelle così indegne esequie, fino al loro ultimo ed esiziale, e traumatico, espletamento.
Gli fu muta l’armonia del giorno un dì cupo di marzo, quando insieme con lui cadde il velo ingannevole e viscido delle illusioni e delle speranze, ed egli cominciò il suo sogno senza sogni.
Da quel momento non so cosa mi sia accaduto. Avrei voluto vedere spento il cielo, estinte la luce delle stelle, stracciate le nubi; non mi importava più niente, dopo che quel mondo, così geometricamente perfetto, mi aveva così tradito e mutilato. Potevano cadere, sfiorire, tutti – tutti! – i fiori, potevano disperdersi e svaporare tutti i loro profumi, tutti gli aromi delle spezie, tutti gli unguenti della gente… Poteva obliarsi per sempre l’amore: non valeva più. Poteva spegnersi anche l’amicizia: non consolava ormai più. E il brillare della luce primaverile – quel brillare dorato crepuscolare – sul mio volto distrutto, sulle mie membra cascanti, mi sembrava l’ennesima umiliazione, un ossimoro di raffinata crudeltà, di divina e somma indifferenza. Non avrei voluto comportarmi così verso il mondo, che vedevo filtrato da un velo di pianto persistente; non avrei voluto nemmeno, però, che egli morisse. Da allora, ogni giorno che rincaso – come ho detto, dopo che molto ho vagato –, per prima cosa, corro nella sua stanza, affondo le mani sotto il velluto delle lenzuola, sotto il cuscino del lato destro del letto, con un velo madido di lacrime che mi sorge sugli occhi, e afferro la maglia del suo pigiama; me la reco, allora, adagio alle narici. Inspiro.
Come se il tempo si squarciasse, e perdesse finalmente il suo rigore, come impietosito dinanzi alla mia tragedia, sembra sovvenirmi un fiume di immagini, di sensazioni, di primissimi ricordi; sento la sua voce antica sfondare le barriere del tempo, trascenderle, e sopraggiungermi, strana e commovente, alle orecchie; sento il suo profumo, di quando viveva ancora. Viveva … che cosa inconcepibile! Egli era stato là, aveva indossato la maglia di quel pigiama, dove sono le mie dita erano state le sue, aveva visto quella stanza, ne aveva inspirato l’aria. Abituato a saperlo morto, è per me adesso impossibile e assurdo che abbia vissuto.
Eppure le sue mani hanno stretto le mie; la sua mano attempata e sapiente si è posata sulla mia testa, sui miei capelli. E le sue pupille, indifferenti ora alla luce del giorno, chiuse in una tenebra lunga, hanno vissuto, hanno veduto, hanno amato! e, specie, mi hanno visto nascere, mi hanno visto crescere, mi hanno visto amare.
Il suo cuore, fermo ormai, ha battuto non molto; ma ha vissuto veramente e onestamente ogni emozione. E la sua voce, obliata dalla terra e da noi tutti, ha riempito della sua profondità queste stanze, e si è più volte indirizzata a me, a me solo, alle mie orecchie.
Ora il deserto. Il frutto di quell’amore fedele, che egli coltivò, va avanti sul sentiero di questa vita; ed è per questo dolore che il crepuscolo non sa più ristorarlo.
Ma in questi giorni vi sono alcune grappoli belli, pendenti da una vite, sul sentiero che mi porta a casa … Succosa, buonissima uva fragola. Vale la spesa, almeno per essa, continuare a vivere? Non vorrei privare le mie papille di quel gusto tenerissimo, e le mie pupille di quel capolavoro di natura.
Dovevi vederla, oggi, quell’uva, illuminata da un fascio di luce, che proseguiva, spezzato, tra gli ostacoli della città.
Più su, le nuvole, distese, placidissime.
Mi è nata, oggi, in cuore, una qualche speranza, una qualche felicità. Ho confortato il mio dramma con quello degli altri: la signora sola e mesta che si portava a casa la sua spesa; il giovane costretto sulla sedia a rotelle; e la madre abbandonata intenta a traghettare a scuola i suoi fiori amati, frutto d’un amore traditore. Bisogna pur perdonarla, la vita; e occorre che si viva con un pizzico in più di leggerezza.
Mi piace credere che nel succo di quell’uva, nei contorni raggianti di essa, nelle nuvole pellegrine, nell’infinità del cielo, ci fosse lui.
Parliamo ancora, in codice, s’intende. Ma parliamo attraverso tali connessioni. Egli è ovunque io voglia che sia: in diafani petali dell’aria, in nuvole transeunti all’orizzonte, in sogni sibillini, in sospiri prolungati. Prima una parte di me era morta con lui; ho capito che è meglio, e più scherzoso, che una parte di lui viva in me. E così continua la sua vita, e la continua in ciò che più amo nella sua. Celeste è questa corrispondenza d’amorosi sensi, celeste dote è in noi. Celestiale è, in fondo, la vita. Ed è il pensiero della morte, in fondo, che invita a vivere.
Posso garantirlo io. Io che cammino su questa strada, e penso, e mando al cielo i miei pensieri, mentre la luce morente di un sole decadente felicemente mi rallegra, e mi rende vivo.
Io, che ho visto l’eclissi della vita. E poi ho visto il suo rinascere.
Celeste, celeste, è tale corrispondenza d’amorosi sensi…
E celeste dote è in noi …