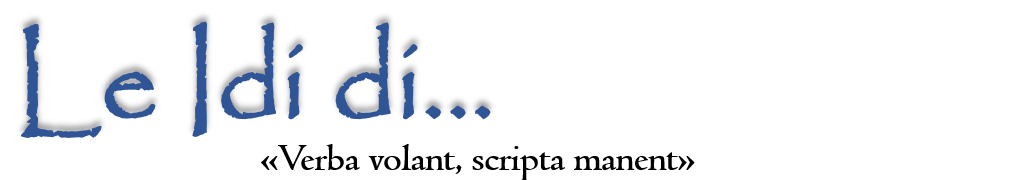di Marco Occhiuto, II C
Il treno fischiava, nel mezzo di insensibili bagagli scarrozzati di qua di là, nel trambusto vuoto, inanimato, assordante di turbe indaffarate, trascinate in furia da un binario a un altro a seconda delle indicazioni raccolte; un sentimento d’ansia e di inquietudine, come un profumo che imbeveva quel luogo, come un’ aria strana che lo riempiva in ogni suo angolo, pervadeva quella stazione, sede di innumerevoli addii e di speranze lontane, al ritmo eguale e fumante d’un treno partito verso altri luoghi, altri mari, altri cieli: verso l’ignoto. Vagoni su vagoni, come serpenti minacciosi e lunghi, si aggomitolavano, fitti, tra i sentieri dei binari, dissolvendosi più diafani rarefatti inconsistenti indistinguibili all’orizzonte, indifferenti alle lacrime più fredde di settembre, ai sospiri, alle malinconie che li seguivano tanto più fermamente quanto più lontano essi si spingevano.
Un alone errante, grigio, un puntino infine, andava dileguandosi allo sguardo amico, familiare, innamorato; scompariva mischiandosi con l’atmosfera nuvolosa, con i vapori d’altri treni, scompariva per lungo tempo offuscato da un velo, sorto in quel momento, d’inconsolato pianto.
Fischio del treno, acuto, pauroso, penetrante. Non avrebbe mai creduto di temerlo tanto, un inanimato fischio, se non che questo portava in sé, oltre alla noia del rumore, un fiume dolce di non so che ricordi, che beatitudini, che giorni o mesi fioriti, che promesse, che speranze, che illusioni…
Non avrebbe mai creduto di temerlo e amarlo insieme e così tanto, un inanimato fischio, se non che quel fischio significava vita, vita che egli non aveva saputo vivere e cogliere fino a quel momento; significava forse – se è lecito dirlo – felicità.
Lui, uomo sempre così assorbito nella vita ridente e spassionata d’un dongiovanni; così fedele maschera di quella parte, ogni giorno della sua esistenza! Amori, i suoi, infiniti quanto le foglie sradicate dall’autunno, quanto le onde offerte da un mare tempestoso. Amori consacrati sulla pelle, in attimi fuggitivi di ebbrezza, in folli fughe di pazzia, in liti dilettose di gelosia. Quegli amori dei romanzi lo avevano affascinato sin dai primi anni della giovinezza ed erano diventati la stella polare del suo navigare sconosciuto.
D’un tratto, lei. Lei, scorta per caso tra le fronde estive, brillanti, mentre schizzi marini s’avvolgevano insieme, a formare un’onda di minuscole gocciole salate, che, formatasi dalla riva, s’infrangeva infine, cadente, sul lungomare. E tra le foglie superstiti, l’abbronzatura dei rami, si modellava sfolgorante una luce invisibile; e si posava infine, in sublime bagliore, sulla testa di lei, seduta di spalle a contemplare il mare, che si stendeva infinito al suo sguardo finito. I capelli, castani, s’indoravano tutti nella zona superiore, esaltati dallo sfolgorio del giorno; e cadevano poi, sensuali e innocenti a un tempo, sulle spalle appena scoperte.
Che strana invenzione, il tempo! Volto alla serie di eventi, dolorosi e felici, della sua esistenza, tutti li avrebbe visti avvolti da un alone ineffabile di confusione: sfumati immaginosi favolosi, come le scene di una miserabile allegra commedia. Non avrebbe potuto distinguere che cosa fosse accaduto prima, che cosa dopo, che cosa con maggiore o minore durata. Tutto si spiegava nella sua memoria, non per tempo, per netta cronologia, ma per importanza, per quei sentimenti che in lui s’erano destati, come le faville scoppiettanti d’un tizzone al fuoco in un falò sulla spiaggia. Quei sentimenti gli sovvenivano, rievocati, più fragili, meno espressivi, come ridotti, sfumati, defraudati, scolpiti dal tempo; e, insieme con loro, veniva, più cupa, un’ombra di malinconica nostalgia, un desiderio vano di rianimare il passato.
Gli stessi eventi che egli aveva organizzato, disposto, vissuto – quelli felici almeno –, gli parevano gli atti inattingibili della più allegra commedia, gli spezzoni di una vita riuscita e fortunata, le gioie d’un personaggio baciato dalla sorte. Eppure, egli stesso se l’era costruite, quelle scene, quella vita! Egli era quel bramato personaggio, inarrivabile ormai!
Aveva vissuto e veduto, con i propri occhi e sensi, quei momenti, che non c’erano più. Era stato tanto inconsapevolmente felice; e a che fine essere felici, felicissimi, se non si sa di esserlo? La felicità non riconosciuta è la tragedia più assurda.
O, forse, la felicità era un’altra ombra, inesistente, che gli veniva insieme con la malinconia, il prodotto, come dire, di una comparazione tra la vita oscura che viveva e quella, appena più lucente, che aveva vissuto.
Quell’ ‘appena’ non era la felicità; eppure, visto dagli sfumanti attimi di un presente angosciante, visto nella zona della morte e della perdizione – e tutto ciò che si perde, si ama e si compiange –, gli sembrava, certo, la felicità.
Il passato, che, presente, gli era non certo granché o, diciamo, normalità, adesso gli appariva la straordinaria eccezione di felicità.
Ma il passato è morto, come le foglie che, a scansione, gocciolano via dai rami, insieme con i raggi declinanti, insieme con gli stormi lontananti. È morto. Morto come tutto il passato prima di lui, come la vita dell’infanzia dimenticata, come gli occhioni innocenti e illibati dei bambini che si è stati.
Tutto ha sradicato con sé, e trasportato in chissà quali inattingibili e reconditi luoghi, arcani. Arcani come il dolore, che, impotente, va a rievocarli nel pianto o in fotografie remote o in trascorsi che non spirano più, irrevocabilmente morti. Non torneranno più.
I soli caduti sugli orizzonti languidi, le nubi di vapore del mare, le faville esili dei tizzoni arsi, riflesse nelle pupille sognatrici, riflesse sulla pelle illuminata dalla luna. E le lune, erranti tra gli spazi delle frasche, sfolgoranti di bianco di perla, tacite, infinite pellegrine mai paghe del mondo.
Il bianco rarefatto, luminoso, d’oro, intangibile, inconsistente del passato – si vedono le nostre mani che, dal presente materiale e duro, disperatamente cercano, a tentoni, di rientrarvi … – il bianco del passato, appunto, è candido, sfolgorante, immacolato. Ma ora un fiume di pece lo varca. Ora il tempo non passa più. Non passava più per lui, almeno, con gli occhi fissi al grande orologio della stazione, a quei gocciolanti e cadenzati battiti, ticchettii lenti e rapidi insieme, che scandivano il tempo vuoto dell’assenza e della lontananza.
Nel cinismo di quei battiti, quel treno – era il suo, stavolta – si disperdeva lontano; e in quel lontano era tutto il suo amato passato, non assai goduto.
Erano i ricordi, i sogni, i momenti di allegria, che, come il sole dell’estate naufrago nel mare, si squagliavano binario per binario, battito per battito.
E ora? Ora che quel treno si disperdeva allo sguardo limitato dei suoi occhi, ora che tutto era finito, ora che fare?
Tornare. Sì, ma dove? Il pensiero della casa, vuota, desolata e deserta, fredda e confusa, lo nauseava. La sola vista, nel pensiero, dei suoi vestiti buttati là, alla rinfusa, e per chissà quanto ancora … che orrore!
Tornare dove, dunque? Vagolare di là e di qua, come le foglie, come i granelli di sabbia nel vento, tra i ponti di Roma; vagolare senza una meta, senza una minima soddisfazione.
Quale insofferenza, quali dolori, quali disincanti vennero a fargli visita, nella più segreta, nella più profonda intimità del suo animo. Come mai in vita sua, pensò a lungo, e quasi con diletto, in quella tenebra ancora estiva d’un settembre giunto a tradimento; pensò e così consolò sé stesso, lasciando che le lacrime portassero via, lungo la pelle, il peso del dolore.
Nelle sere estive la sera tarda a velare il paesaggio di sé; il cielo si tinge di scarlatto, d’arancio, di viola su sdruccevoli orizzonti, e altrove colori lividi e più bui adombrano la luce. Dolcemente, poi, come una giovane vita che man mano si inaridisce all’irreparabile gocciare delle stagioni, il cielo si scolora, si intristisce, fin quando incominciano, rade, a brillare le stelle.
Stelle sparse, biancheggianti sul cielo, pigolanti lievemente, come la cima d’una fiamma al declino, smunta e tremolante.
Un soffio di vento sarebbe in grado di spegnerle. E più scende la notte, più loro s’accendono; e più tace la natura, più esse cantano. Le luminose danzatrici del cielo si concedono agli occhi-specchio della gente terrestre- e sul velo umido ed emozionato dell’iride, si amalgamano al più profondo, al più nascosto sentire, che emerge concreto sulla superficie.
Vita umana, così affannata e piangente galleggi, luccicante, sugli occhi! Così abbattuta e umile, t’abbandoni al naufragio delle stelle! Così celestialmente si corrispondono occhi mortali e finiti e astri immortali e infiniti!
Osservando, nel buio della siepe, svolazzare luminose le lucciole, pensava a tutto ciò; e pensava, poi, ai tempi già morti della sua felicità, mentre quei lampi di luce animale gli ricordavano i guizzi di gioia trascorsi, il chiarore negli occhi di lei – naufragio tenero e stellare …
Il tempo contava i propri palpiti con parsimonia, posandoli ora sul dorso di foglie inaridite, ora sulle piccole gocciole d’acqua piovana, ora sul suono cadenzato ed estenuante d’un pendolo; più ancora li ancorava ai canti degli uccelli, attivi a tratti, e per poco, dal buio di fitte sterpaglie, oppure, più poeticamente, li incollava, nel ricordo estivo, al frinire incessante, e lungo, delle cicale notturne.
Tale era la sua compagnia, mentre il passare del tempo, magra consolazione, avveniva lentamente, e quei secondi che dovevano, a mano a mano, costruire i mesi dell’attesa, s’andavano, radi e insufficienti, a sommare, a unire, a ritrovare.
Il cuore lo portava per mano, intanto, per gomitoli sciolti di strade, nei luoghi simbolo di lei, che di lei recavano impressa ancora la traccia, l’impronta, la voce; dove gli alberi, intenti a stormire, ora come allora, trasudavano il suo respiro, lo veneravano, lo piangevano; e stillavano, nell’aria umida e invernale, i guizzi degli occhioni di lei – specchi di stelle – , vivi nel solo ricordo. Là era stata, e là le era piaciuto, fare,di quel ramo stesso, gentile ed in fiore, al bel fianco colonna.
Ora vi si posava lui, poggiando la testa alla corteccia, che rispondeva alle lacrime che la vellicavano con il sudore freddo del suo legnoso, ma dolce, velluto, intriso ancora di lei.
Quell’aria aveva raccolto le sue parole, le sue sillabe, i suoi accenti; aveva dato luogo alle sue espressioni, ai suoi sorrisi, ai suoi sospiri. Ora quell’aria accoglieva lui, sconsolato, vivo nel solo ricordo di vita, della vita vera, e viva, che ebbe con lei.
Poi, più in là, sul muretto scalcinato e dipinto del Lungotevere, estendersi infinito il Tevere, curvarsi su sé, coccolarsi, cercare quiete. Acque chiare, divertite da tinte di luci accese su per le vie, fresche, imbevute di petali riarsi e galleggianti, e dolci, perché rifugio degli amanti, dei loro sogni e di quelle promesse incerte che si consacrano sui muri, imbalsamate nell’inchiostro.
Il correre sfumante e svanente di quelle acque gli sarebbe tornato alla memoria, per similitudine con le nuvole svelte d’agosto, al calar lento del sole, mesi più tardi.
I secondi erano trascorsi, volati, come trascorrono gli incubi al risveglio e come volano le mosche al minimo movimento di minaccia.
Non dormì tutta la notte, pensando a lei, al suo sorriso, ai suoi occhi, ai ricordi che nutriva di lei. I quali ricordi, di nuovo vivi, si imposero alla sua mente, che oscillava, come un pendolo, tra trepidazione e paura.
Sentiva sulle spalle il velo dei suoi capelli crespi e brillanti, e sulle labbra il sapore innocente d’un rossetto consumato, e negli occhi il baleno sublime della sua figura.
Dieci minuti di sonno, non più.
Andava verso la stazione: lei voleva così.
Ci vediamo alla stazione. Ore 9:30. Baci
Gli aveva scritto così.
Sarà che gli eventi che di più si aspettano cominciano a svilirsi quanto più li tocca e invade la realtà, sarà che il tempo sfuma e dissolve l’ardore dei sentimenti, sarà che la stanchezza d’una notte insonne addormenta e silenzia, nel più tacito singulto e nel più vile buio, la bellezza della vita e delle cose, ma lì per lì, quel mattino d’un maggio atteso con incredibile passione, la felicità semplicemente mancava.
Gli alberi rinverdivano, e rinverdivano i sogni e le speranze e, insieme con loro, le promesse dell’estate, mentre, guizzanti, i bambini andavano di là e di qua, ridenti e fuggitivi, intenti a seguire il volo d’un pallone o l’allontanarsi in cielo d’un aquilone.
Egli passeggiava tra la vita impetuosa di sempre, tra i sorrisi e le lacrime di tutti; ed era uno in mezzo agli altri. Uno che aveva atteso e sperato tanto, e mantenuto limpida la bocca, che attendeva di posarsi su quella di lei sola.
Lei, straordinaria immagine di felicità, impressa nei suoi ricordi come non lo erano i cari perduti, i suoi più familiari. Quegli occhi, cui aveva detto addio, tempo fa, nel vapore e nei fischi dei treni, nel sapore acerbo delle lacrime!
Lei stava tornando, dopo tanta attesa, dopo tanto tempo!
Eppure, ora che quel sogno, che era lei, tornava, quanto più esso assumeva le forme vagheggiate della realtà, tanto più perdeva in valore, tanto più gli sembrava vano.
Vano! Come quella estate arrivata: dopotutto, ma a che prezzo! Avrebbe potuto essere felice sempre, in ogni stagione! La causa della sua infelicità era lui medesimo, e lui era con lui d’inverno, d’estate, d’autunno.
Ma via! Non poteva, certo, essere scontento, proprio alle soglie del suo arrivo, proprio all’inverarsi del suo più intimo desiderio.
Erano, di certo, la stanchezza accumulata, il frapporsi della più ignote cause psicologiche, a creargli quel miserabile effetto.
Davanti ai binari, si ricordò di quell’addio di mesi prima. Riapparve, violento, nei suoi pensieri quel treno lontanante e insensibile; riapparvero le lacrime e i sospiri, i volti desolati e malinconici, i desideri infranti e le promesse tradite.
Ma poi, poi ecco quel treno, di nuovo, adesso, tornare! Tornare! Tra gli altri che partivano, quel suo treno tornava! Si avvicinava, non fuggiva più.
E quanto più era vicino, tanto più si accendeva, in lui, un sentimento strano e inatteso, ma forse – pensava – comprensibile, di paura.
Lunghi pali di ferro, il suono delle ruote sui binari, i pianti dei bambini e il trambusto delle valigie.
Un tale, assorto nello studio, non si era accorto di essere quasi arrivato: ancora leggeva, sottolineava, pensava.
Lei stava seduta, con le mani sul tavolino, con tanti pensieri nell’animo, e con gli occhioni fuori dal finestrino.
Che occhi! Non potevano non infondere, in chi vi si immergeva, un’elevatezza di sentimenti, una tenerezza sublime: brillanti, parevano le acque placide di un molo, nel più placido orario, illuminate teneramente, e a guizzi discontinui, a tratti irregolari, dalle più vivide stelle del cielo.
La pupilla biancheggiante come stella, o come la luna, in una sera scura d’estate, che indora i campi e le valli. Mai asciutti, mai apatici, era come se il più profondo sentimento del cuore, incapace di contenersi là interamente, si spingesse lontano e, come per prodigio, emergesse, materiale e vivo, sulla superficie degli occhi, sotto forma d’un velo umido e sfolgorante e profondo.
Quel sentimento incarnato, rarissimo e vibrante, al suono delle stelle, al ritmo delle luci, induceva a un dolce naufragio ogni osservatore!
E vi indussero, ora come allora, lui, che le corse incontro, non appena la vide scendere dal treno.
Pioveva. D’un tratto pioveva. Forse perché, per la prima volta, la pioggia volle fondersi con le lacrime degli uomini e annegarsi, essa stessa, nei loro mortali sentimenti.
La guardava: era bella come prima, era dolce come sempre.
Ma alla sincerità infinita di lei egli rispondeva con sincerità.
Non poteva non accorgersi che, al di là degli abbracci e dei baci e dei sorrisi, qualcosa in lui era cambiato.
Non aveva amato un’altra donna fuori di lei, non aveva aspettato nient’altro che lei. Eppure, forse per i giochi strani e malvagi della vita, qualcosa in lui era cambiato. Il fatto era, forse, che l’aveva conosciuta e amata, la prima volta, per caso, senza attendere nulla, mentre adesso un’attesa trepidante e lunga, una speranza coltivata e piacevole, erano venute a guastargli quella bellezza che è propria di tutto ciò che non è aspettato.
Con l’andare dei giorni, aumentò inevitabilmente la sua malinconia.
Si separarono, come si separano due foglie nate da uno stesso ramo, come si allontanano due petali di uno stesso fiore.
Lui – si chiamava Michele Tenni – morì pochi mesi dopo, per un incidente stradale, senza aver mai saputo amare, non per cattiveria, ma piuttosto per una sua incapacità naturale, congenita.
La vita di lei andò diversamente. Quando si allontanò da lui, quel giorno di settembre in cui si divisero per sempre, si lasciò andare al più grande dolore.
Finita, poi, per caso, su una panchina logora e rossa, vi si accasciò triste e disperata. Al passare della luce tra le fronde, e al muoversi, tra esse, del vento, che le si posava, cauto, sul volto e sul grembo, avvertì qualcosa con sgomento.
Sentì come muoversi dentro di sé qualcosa che quell’uomo, ora lontano, le lasciava, come triste ricordo.
Ma un ricordo indelebile, palpitante, incarnato.
Quella vita che l’aveva tradita, che continuava a muoversi attorno a lei sotto forma di natura viva e vivificatrice, quella vita a cui lei, Anna, non voleva mai più prendere parte, le entrava dentro di forza, e rinasceva, e viveva, in un’urna molle e segreta, dentro di lei.